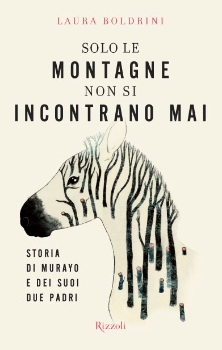Paolo
Poli e Ninetto Davoli sono i pochi personaggi famosi che rendono la
loro testimonianza nel documentario di Gianni Amelio, dal titolo
Felice chi è diverso,
presentato in anteprima a Milano lo scorso 8 marzo al cinema Mexico e
passato alla scorsa edizione del Festival di Berlino. Gli altri
protagonisti sono persone comuni, di tutta Italia e di varia
estrazione sociale: persone che si raccontano come omosessuali, come
coppie, come amanti nel senso di “coloro che amano”.
L'originalità
del film consiste nel parlare di “diversità” attraverso il
vissuto di persone anziane e di frammezzare il racconto con spezzoni
di altri film celebri, cinegiornali e pagine di riviste
scandalistiche anni'50, come Lo
specchio o Il
borghese, che
rimarcavano pregiudizi e stereotipi spesso offensivi. Anche nel
documentario di Amelio non si usano termini politically correct,
quali omosessuale o gay, ma si sentono pronunciare parole come:
“finocchio”, “invertito”, “femminiello”. A volte per
biasimarne l'utilizzo, ma più spesso per sdoganarlo, per rivendicare
l'orgoglio di amare chi si vuole e di vivere le stesse emozioni e gli
stessi sentimenti di tutti.
Certo,
le persone intervistate parlano di clandestinità, di umiliazione, di
derisione, di emarginazione: raccontano di aver vissuto in periodi
storici in cui era davvero difficile fare coming
out, ma siamo sicuri che,
oggi, ci sia più libertà, che la diversità (soprattutto
dell'orientamento sessuale) sia accettata ?
Una
coppia di signori torinesi accenna alla necessità di estendere i
diritti di base ad ogni tipo di famiglia; nel film le persone
intervistate sono in maggioranza di genere maschile e restano sullo
sfondo le coppie formate dalle donne: qualcosa, forse, nella società
sta cambiando, ma se è necessario un documentario per approfondire e
riflettere sull'argomento, vuol dire che c'è ancora tanta strada da
fare.
Diventa
necessario, il lavoro del regista calabrese, perchè racconta il
percorso culturale di un secolo di Storia italiana, dalla caccia alle
streghe durante il periodo fascista ai giorni nostri; perchè è un
buon manifesto contro l'omofobia ancora imperante, nonostante alcuni
passi avanti fatti dalle istituzioni e dai cittadini; e perchè
propone la capacità di vivere l'amore, tra persone dello stesso
sesso, con equilibrio, con gioia e con rispetto. E, di questi tempi,
non è poco.

.png)