Pochi giorni fa, a Roma, un Rom di diciasette anni, senza patente, mentre si trovava alla guida di un'auto ha ucciso una donna e ferito altre nove persone. Un fatto gravissimo, che va punito severamente. Questo, però, non deve far cadere nell'errore di considerare TUTTI i Rom allo stesso modo, ovvero come delinquenti assassini; non bisogna fare l'errore di scadere nello stereotipo. Colpire i colpevoli sì, colpire tutti indistintamente, no.
A questo proposito, pubblichiamo la nota dell'Associazione 21 luglio:
La
notizia della tragedia avvenuta ieri a Roma in prossimità della
fermata metro Battistini, nella quale una donna di 44 anni ha perso
la vita e otto persone sono state ferite, travolte da un’auto che
viaggiava a folle velocità, addolora
e sconvolge.
Con
l’auspicio che il corso delle indagini conduca all’individuazione
dei responsabili di tale gesto, l’Associazione 21 luglio non può
non constatare, tuttavia, che la notizia, come è stata riportata da
molti media locali e nazionali, rischia di sfociare in una pericolosa
deriva etnica
dei fatti accaduti, in quanto ad essere sottolineata con forza è la
presunta origine etnica dell’autista dell’autovettura che ha
provocato la strage.
Le
colpe di un gesto di tale gravità non possono e non debbono ricadere
sull’insieme di persone appartenenti alla stessa comunità degli
autori della strage, a Roma e nel resto d'Italia. E gli organi di
informazione dovrebbero prendere tutte le opportune
precauzioni
perché questo non accada, evitando per esempio titoli, articoli e
servizi che diano rilevanza
maggiore all’origine etnica dei responsabili piuttosto che al fatto
- gravissimo - in sé.
L’etnicizzazione
delle notizie,
infatti, rischia di esacerbare il già esasperato clima di ostilità
e odio diffuso nell’opinione pubblica nei confronti di rom e sinti.
Simili trattamenti delle notizie portarono già, ad esempio, a derive
fortemente violente, in passato, a Ponticelli (Napoli) nel 2008 e a
Torino nel 2011, quando contro i “campi rom” si svilupparono, in
seguito alla diffusione di notizie poi rivelatesi infondate, veri
e propri raid incendiari.
Per
chi sarà chiamato ad indagare e per i giudici, nella ricostruzione
dei fatti e nella successiva auspicabile condanna, poco
importa l’origine etnica della persona colpevole,
o la
sua cittadinanza
o il
colore della sua pelle.
Alla guida di quella macchina c’era una persona che va perseguita.
Questo
basta e avanza.
Se
dovesse scoprirsi che dietro quel volante omicida c’era una persona
di origini islamiche dovremmo tornare a invocare le misure del post
11 settembre 2011? O se c’era una persona di origini campane o
venete dovremmo aprire una discussione sulla presenza di tali
comunità nella nostra città?
L’isteria
mediatica, declinata in una “etnicizzazione
del reato”
fa danni. Così come lo fa il razzismo. E razzismo è anche
ricondurre il DNA di un popolo al crimine di un individuo.

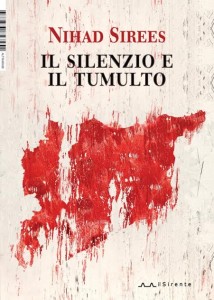
.jpg)



.jpg)
.jpg)





.png)




